Ieri mattina alla Messa delle otto mi sono accorto che molti posti erano rimasti vuoti: molti, beati loro, sono in vacanza o perchè gli esami si avviano alla loro conclusione o perché l’anzianità permette le vacanze quando si vuole e nella quantità desiderata.
Mi sono quindi accorto che la pausa estiva ormai incombe: non ci sono più i soliti volti …
Ma altri volti, nuovi e sconosciuti, si sono fatti avanti nella giornata: chi per un bisogno immediato, chi per una domanda che si dilata nel tempo, chi per una indicazione o per un suggerimento, e la cosa mi ha colpito moltissimo.
La prima reazione, sbagliata come ogni reazione, è stata quella di chiedermi se arriverà anche per me un momento di quiete, pensavo: “questa girandola di volti mi sa tanto di fregatura” e quindi la preoccupazione di trovare ad agosto un modo di poter essere un pochino tranquillo.
In seconda battuta ho iniziato a chiedermi perché capita che la gente arrivi a me; la sola risposta convincente che mi sono dato è che sono facilmente accessibile e quindi è più semplice chiedere a uno che sai che c’è piuttosto che chiedere a qualcuno che non sai nemmeno se troverai.
La cosa che invece mi ha stupito davvero, chi come me è un pò tonto e ha bisogno dei suoi tempi, è stato il rendersi conto che un tale vortice di facce è proprio quello che il buon Dio ha scelto per non lasciarmi in pace, perché io non mi accontenti né di me né delle cose che faccio.
dalla liturgia ambrosiana:
Martedì della V° domenica dopo PENTECOSTE
memoria di san Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa
Nacque a Bagnoregio, presso Viterbo, intorno al 1217. Come lui stesso racconta, da bambino fu guarito miracolosamente da una grave malattia per un voto fatto dalla madre a san Francesco.
Entrò nell’ordine francescano venticinquenne, dopo aver fatto gli studi di filosofia all’Università di Parigi, dove compì pure il quinquennio teologico sotto la guida di Alessandro di Hales, suo venerato magister et pater, diventando lui stesso Maestro. Nel 1257 fu eletto ministro generale dell’Ordine e rimane alla sua guida per diciassette anni, fino alla morte, nel periodo difficile del suo grande sviluppo, preservandolo dagli eccessi sia dei fratelli zelanti che dei fratelli rilassati.
Fedele allo spirito di san Francesco, col prestigio della sua autorità e della sua santità mantenne unito l’Ordine che contava già trentamila frati, ne fu il saggio legislatore e il moderatore, insuperato interprete e modello della vita francescana. Nella sua riflessione teologica i metodi della scolastica si incontrano in modo geniale con lo spirito francescano e il suo ardente desiderio di Dio.
Sotto la costante guida delle Scritture, Bonaventura operò una sintesi mirabile tra la nascente teologia speculativa medioevale e la mistica incentrata sull’interiorità, tipica dei cistercensi e dei vittorini. Dopo aver rinunciato all’arcivescovado di York, dovette accettare il cardinalato e il vescovado di Albano; partecipò ai lavori preparatori del concilio ecumenico di Lione per l’unione con i Greci, e poi al concilio stesso. Una settimana dopo la conclusione dell’assise conciliare, morì assistito dallo stesso papa, il 15 luglio 1274. Anche la Chiesa anglicana oggi fa memoria di san Bonaventura.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. Non c’è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate; perché a chi ha, sarà dato, ma a chi non ha, sarà tolto anche ciò che crede di avere».
Vangelo secondo Luca 8,16-18.
La luce è la luce, non serve né spiegare cos’è e neppure provare a spiegare perché è utile, Gesù considera quindi cosa scontata che questo esempio sia a tutti chiaro ed evidente. D’altra parte sarebbe un esempio illogico se non esistesse nessuno così stordito da mettere la lucerna sotto un vaso.
Tutto questo per metterci in guardia dal dire che la cosa non ci riguarda: se c’è qualcuno così stranito da mettere la propria lampada sotto il letto, allora quello stranito che compie quel gesto illogico potrei essere io.
Basta considerare dove mettiamo tanta Grazia di Dio che spesso vediamo e poi non mettiamo sul candelabro perché faccia luce a tutti.
Già facciamo fatica a vedere la Grazia che accade e poi ci fermiamo a goderne senza avere il problema che anche altri ne possano godere.
Ieri la parabola della semente mi induceva a pensare che non ci soffermiamo quasi mai sul nostro essere “semi”, oggi la questione, in modo diverso, torna tale e quale.
E’ il tema della testimonianza come dimensione della vita e non come impegno che talvolta ci richiamiamo.
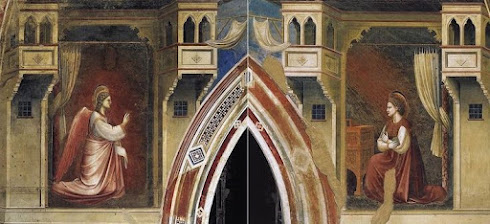
Scuola di Comunità
IL SENSO RELIGIOSO
Capitolo 14
L’energia della ragione
tende a entrare nell’ignoto
5. Idoli
La Bibbia chiama con un determinato nome il particolare con cui la ragione identifica il significato totale del suo vivere e dell’esistere delle cose. Questo particolare nel quale la ragione identifica la spiegazione di tutto, la Bibbia la chiama idolo. Qualcosa che sembra Dio, la maschera di Dio, e non lo è.
La cosa che mi colpisce è quell’idea che la ragione spinga su un particolare conosciuto sino a ritenerlo origine e fine della vita stessa. L’idolo è qualcosa che faccio io e che “sfugge” da me chiedendo che io gli appartenga. Ma come posso appartenere a qualcosa che tengo tra le mani?
Eppure chi ama desidera proprio questo: possedere ed essere posseduto da quel rapporto che vive, ma perché la cosa si spalanchi e duri all’infinito occorre che quel particolare, l’amore che mi compie ora, sia rimesso dentro il rapporto che ha fatto me e l’altro.
Buon martedì,
donC

Lascia un commento