Che stridore umano!
Ieri mi hanno colpito due cose, la sottolineatura del compleanno di papa Leone, il primo da Papa, con tutte le immagini dei disegni dei bambini, le scritte e la festa in piazza e, dall’altra parte la notizia sul “Corriere” che la tomba di papa Francesco è già stata dimenticata, nel senso che non ci sono più file di pellegrini che passano a pregare.
Tanto pare di essere considerati agli occhi del mondo e tanto rapidamente quello stesso mondo, nella sua folle corsa, passa al personaggio successivo.
Sia chiaro, con questo non sto affatto dicendo che il papa Leone non mi vada bene, semplicemente constato che il nostro tempo non ha nè memoria nè reale gratitudine.
Avevo questa considerazione nella testa quando ieri pomeriggio ho sentito cantare a una sola voce, da undicimila persone, il “Discendi Santo Spirito”.
Lì mi è stato chiaro: passa la scena di questo mondo, passa la memoria del singolo, resta invece un popolo che cammina e che cammina insieme, facendo la storia.
Un popolo e non singoli, che canta e cammina, quando lo sguardo che si guarda all’orizzonte è comune.
Forse dobbiamo tornare a prendere coscienza che il nostro io fiorisce in un incontro, in un popolo, che lo custodisce.
dalla liturgia ambrosiana:
Lunedì della III° settimana dopo il martirio del Precursore
Memoria della B.V. Maria Addolorata
La Vergine Addolorata ha avuto sempre nella Chiesa una venerazione particolare; sempre infatti si è vista la Madre sotto la croce, associata alla passione del Figlio. Della memoria liturgica si trova traccia, già alla fine dell’XI secolo, negli scritti di sant’Anselmo e di molti monaci benedettini e cistercensi.
Si diffuse poi nei secoli XII e XIII ad opera degli stessi cistercensi e dei serviti, un ordine dedicato – come i sette fondatori avevano indicato istituendo la “Compagnia di Maria Addolorata” – alla devozione della Madonna. Nel 1667 i Serviti ottennero l’approvazione della celebrazione liturgica dei “Sette dolori della Vergine”, che corrispondono ad altrettanti episodi narrati nel vangelo: la profezia di Simeone, la fuga in Egitto, lo smarrimento di Gesù a 12 anni nel Tempio, la salita al Calvario, la crocifissione, la deposizione dalla croce, la sepoltura.
Durante il pontificato di Pio VII, nel 1814, la festa venne accolta nel Calendario Romano alla terza domenica di settembre; Pio X, nel 1913, fissò la data definitiva al 15 settembre. Celebrata dopo la festa dell’Esaltazione della Croce, questa memoria riceve così un ricentramento cristologico, passando dalla contemplazione dei sette dolori della Vergine, al dolore della Madre, che sul Calvario assume dimensioni universali generando alla vita tutti coloro che Gesù salva. Maria sta in piedi sotto la croce, sostenuta dalla speranza e dalla fede, per sostenere i credenti nelle loro prove e insegnare loro a stare presso le infinite croci dei nostri fratelli.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell’uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel giorno in cui Lot uscì da Sòdoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle; così, chi si troverà nel campo, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma chi la perderà, la manterrà viva».
Vangelo secondo Luca 17, 26-33.
La tentazione di non voler vedere è cosa comune, oggi come ai tempi di Gesù, e credo sin da Adamo ed Eva. Di fronte al male che ci sovrasta il tentativo, quasi innato, è cercare di allontanare il peso della realtà, fingere che tutto sia come deve essere.
L’impossibilità di poterci dare da soli la salvezza comporta la coscienza del chiedere aiuto, ma se continuiamo, sottilmente, a pensare a noi come ai padroni della nostra vita, allora di fronte ai limiti dobbiamo solo fingere la normalità. Ecco, chiedere aiuto è la questione.
Attenzione però a una cosa: chiedere aiuto è una dimensione della vita, quella che rende l’uomo mendicante nel cuore prima ncora che nella posizione concreta di chi chiede aiuto.
Per questo la preghiera di ogni giorno, più volte al giorno, comincia con quel “O Dio vieni a salvarmi”. Per questo il papa, prima Francesco e poi Leone, ci invita continuamente a pregare per la pace. Per questo i peccati dovrebbero essere un aiuto a spostarci dalla nostra misura della raltà, misura per cui possiamo permeterci di credere che vada tutto bene.
“Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà”; cosa significa concretamente perdere la vita? Per chi o per cosa la perderemmo?
Leggiamo il testo della catechesi giubilare
del mercoledì
Giubileo 2025.
Gesù Cristo nostra speranza.
III. La Pasqua di Gesù.
6.La morte. «Gesù, dando un forte grido, spirò» (Mc 15,37)
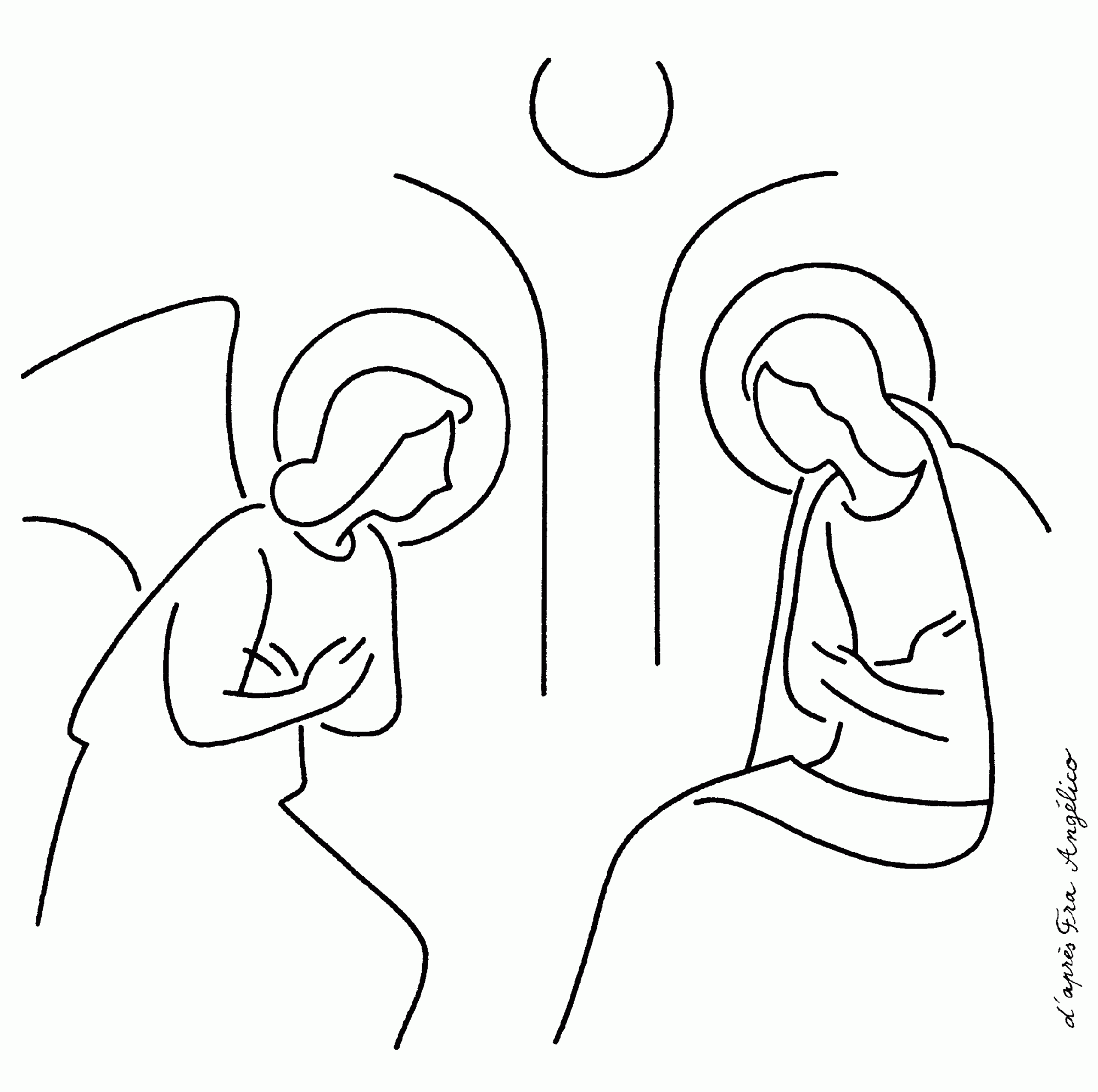
Fratelli e sorelle,
buongiorno e grazie per la vostra presenza, una bella testimonianza!
Oggi contempliamo il vertice della vita di Gesù in questo mondo: la sua morte in croce. I Vangeli attestano un particolare molto prezioso, che merita di essere contemplato con l’intelligenza della fede. Sulla croce, Gesù non muore in silenzio. Non si spegne lentamente, come una luce che si consuma, ma lascia la vita con un grido: «Gesù, dando un forte grido, spirò» (Mc 15,37). Quel grido racchiude tutto: dolore, abbandono, fede, offerta. Non è solo la voce di un corpo che cede, ma il segno ultimo di una vita che si consegna.
Il grido di Gesù è preceduto da una domanda, una delle più laceranti che possano essere pronunciate: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». È il primo verso del Salmo 22, ma sulle labbra di Gesù assume un peso unico. Il Figlio, che ha sempre vissuto in intima comunione con il Padre, sperimenta ora il silenzio, l’assenza, l’abisso. Non si tratta di una crisi di fede, ma dell’ultima tappa di un amore che si dona fino in fondo. Il grido di Gesù non è disperazione, ma sincerità, verità portata al limite, fiducia che resiste anche quando tutto tace.
In quel momento, il cielo si oscura e il velo del tempio si squarcia (cfr Mc 15,33.38). È come se il creato stesso partecipasse a quel dolore, e insieme rivelasse qualcosa di nuovo: Dio non abita più dietro un velo, il suo volto è ora pienamente visibile nel Crocifisso. È lì, in quell’uomo straziato, che si manifesta l’amore più grande. È lì che possiamo riconoscere un Dio che non resta distante, ma attraversa fino in fondo il nostro dolore.
Il centurione, un pagano, lo capisce. Non perché ha ascoltato un discorso, ma perché ha visto morire Gesù in quel modo: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!»(Mc 15,39). È la prima professione di fede dopo la morte di Gesù. È il frutto di un grido che non si è disperso nel vento, ma ha toccato un cuore. A volte, ciò che non riusciamo a dire a parole lo esprimiamo con la voce. Quando il cuore è pieno, grida. E questo non è sempre un segno di debolezza, può essere un atto profondo di umanità.
Noi siamo abituati a pensare al grido come a qualcosa di scomposto, da reprimere. Il Vangelo conferisce al nostro grido un valore immenso, ricordandoci che può essere invocazione, protesta, desiderio, consegna. Addirittura, può essere la forma estrema della preghiera, quando non ci restano più parole. In quel grido, Gesù ha messo tutto ciò che gli restava: tutto il suo amore, tutta la sua speranza.
Sì, perché anche questo c’è, nel gridare: una speranza che non si rassegna. Si grida quando si crede che qualcuno possa ancora ascoltare. Si grida non per disperazione, ma per desiderio. Gesù non ha gridato contro il Padre, ma verso di Lui. Anche nel silenzio, era convinto che il Padre era lì. E così ci ha mostrato che la nostra speranza può gridare, persino quando tutto sembra perduto.
Gridare diventa allora un gesto spirituale. Non è solo il primo atto della nostra nascita – quando veniamo al mondo piangendo –: è anche un modo per restare vivi. Si grida quando si soffre, ma pure quando si ama, si chiama, si invoca. Gridare è dire che ci siamo, che non vogliamo spegnerci nel silenzio, che abbiamo ancora qualcosa da offrire.
Nel viaggio della vita, ci sono momenti in cui trattenere tutto dentro può consumarci lentamente. Gesù ci insegna a non avere paura del grido, purché sia sincero, umile, orientato al Padre. Un grido non è mai inutile, se nasce dall’amore. E non è mai ignorato, se è consegnato a Dio. È una via per non cedere al cinismo, per continuare a credere che un altro mondo è possibile.
Cari fratelli e sorelle, impariamo anche questo dal Signore Gesù: impariamo il grido della speranza quando giunge l’ora della prova estrema. Non per ferire, ma per affidarci. Non per urlare contro qualcuno, ma per aprire il cuore. Se il nostro grido sarà vero, potrà essere la soglia di una nuova luce, di una nuova nascita. Come per Gesù: quando tutto sembrava finito, in realtà la salvezza stava per iniziare. Se manifestata con la fiducia e la libertà dei figli di Dio, la voce sofferta della nostra umanità, unita alla voce di Cristo, può diventare sorgente di speranza per noi e per chi ci sta accanto.
Buon lunedì,
donC

Lascia un commento